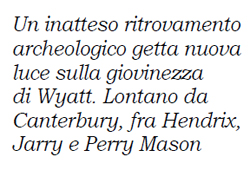| |
|
|
 Robert Wyatt - Il Sessantotto di un patafisico - Musica Jazz - N. 757 - Dicembre 2013 Robert Wyatt - Il Sessantotto di un patafisico - Musica Jazz - N. 757 - Dicembre 2013
|

|

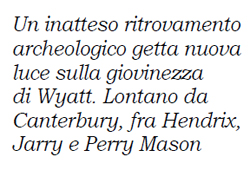 Di Riccardo Bertoncelli
Di Riccardo Bertoncelli
 |
|

|
Soft Machine prima versione si erano sciolti. Mike era tornato a Londra, Kevin si era trasferito a Maiorca. La casa discografica non sapeva dello scioglimento e fra l'altro doveva ancora pubblicare il primo lp, registrato già da sei mesi. Insomma, non avevo vincoli, e c'erano un po' di cose che volevo fare e che non potevo in una situazione di gruppo come quella di allora».
Robert Wyatt ambienta così un delizioso ed appena uscito, «'68», con quattro suoi provini registrati fra i Ttg Studios di Hollywood e il Record Plant di New York nel autunno 1968, tra ottobre e i primi di novembre. Jimi Hendrix, che ha appena condotto un tour americano con i Soft Machine di spalla, affitta quegli studi per stare dietro alla sua bulimia musicale e volentieri regala qualche ora al giovane batterista che nel corso del tour è diventato amico suo e di Mitch e di Noel. Le sedute di «Electric Ladyland» sono terminate da poco; Jimi ha altre idee ma da quelle sedute non cava granché. Robert invece spende bene il suo tempo. Mette a fuoco una serie di frammenti che gli fluttuano in testa e con il tempo prenderanno magica forma, e ha modo di metter mano a strumenti che nel quotidiano non potrebbe mai permettersi, tipo un organo Hammond su cui golosamente pasticcia. Alla fine si ritrova tre quarti d'ora di musica imperfetta ma stimolante, che sarebbe
bello avere su un master ma chi può
permetterselo? Si fa fare degli acetati; poi
se ne dimentica e i nastri rimangono nella
pancia profonda dei Ttg (che prendono
il nome – forse non tutti sanno che – da
un reggimento dell’esercito israeliano in
cui era arruolato il proprietario degli studi,
il ruvido prepotente tecnico del suono
Ami Hadami).
Wyatt è un fenomeno. Giura di avere una
memoria di camembert, casca dalle nuvole
quando qualcuno ritrova i nastri e lui nemmeno
se ne ricordava; però se lo stimoli
lascia gocciolare deliziosi aneddoti e piano
piano prende forma uno straordinario
racconto, che da un lato avvince e dall’altro
fa digrignare i denti – perché Wyatt
non ha mai deciso di scrivere per bene e
di persona, con la sua lingua placida, con
il gas esilarante del suo understatement, le
memorie della vita? A ogni modo, i Soft
Machine accompagnano la Experience in
giro per l’America due volte nel 1968, in
primavera e poi fra agosto e settembre. La
seconda volta il tour finisce in California
e lì Jimi decide di fermarsi, a Los Angeles,
affittando una sorta di ampio bungalow
a Benedict Canyon. Ha un letto che
gli avanza e generosamente lo offre a Robert.
Vuole la leggenda che quello spazio
servisse ai produttori di Perry Mason per le
registrazioni del telefilm; ma fra una serie
e l’altra c’erano pause e il bungalow veniva
messo a disposizione. Il ragazzo di Canterbury
si tuffa nel delirante mondo della
Plastic City ma uno scetticismo molto
Brit ne protegge la sanità mentale. Non
ne resta abbagliato, non si fa traviare da
quel teatrino di Doors e Laurel Canyon,
di Zappa e Easy Rider e Crosby, Stills &
Nash. Lo stesso distacco mantiene quando
ai primi di novembre si muove a New
York, sempre seguendo gli spostamenti di
Hendrix, e scopre che «della Mecca jazz
che avevo costruito nella mia immaginazione
non rimaneva più nemmeno l’ombra
». Una sera fa un salto al Village Vanguard
e nota per strada un poveraccio che
ha tutta l’aria del mendicante. È Wilbur
Ware, gli dicono, e quasi non ci crede:
Wilbur Ware! Quante fantasie ascoltando
il suo contrabbasso nei dischi di Art
Blakey, Monk e Trane.
A New York Wyatt va a stare da una amica,
Phillys, ma si tiene in contatto con Jimi
che gli offre ancora ritagli di studio.
Passa un paio di mesi in un appartamentino
al quinto piano di un palazzo del Greenwich,
con una pianola elettrica in cucina
su cui continua a rifinire la sua musica,
quella generata da migliaia di ascolti
giovanili che cominciano a dare frutto,
quella che il primo album Soft Machine
ha recepito solo in minima parte. Gli piace
l’idea di canzoni poco ortodosse, che si
dilunghino oltre lo schema dei tre minuti
classici reso obsoleto dall’avvento del
long playing; temi che appaiono e scompaiono,
pause, cambi di passo – senza un
senso preciso, con il gusto della sorpresa.
Moon In June è da subito la creatura preferita.
Fra i Ttg e il Record Plant ne registra
una versione piuttosto evoluta, non così distante da quella «ufficiale» per il Third che prenderà forma nella primavera 1970.
È sempre un bell’ascolto, con il testo che
segue le lune del momento e questa prima
volta è ambientato naturalmente «in
New York State», ma non è la perla del
nuovo disco; perché in parte la conoscevamo
già (stava sul cd di materiali d’archivio
«Backwards») e perché solo la prima
sezione è autenticamente «americana», il
resto viene da un provino di qualche mese
più tardi una volta a casa, con l’aiuto di
Hopper e Ratledge.
Anche Slow Walkin’ Talk la conoscevamo,
per via della stessa antologia e di varie
raccolte hendrixiane, dato che il basso
lo suona Jimi. È «una cosina alla Mose
Allison» (per dirla come Robert nell’intervista-
intro) scritta da Brian Hopper e
adottata dal giovane Wyatt, che non se
ne dimenticherà. Hendrix la ascolta e si
offre di dare una mano, il nastrino è un
bijou però finisce negli archivi, senza mai
entrare nell’orbita Soft Machine. Ma a
WyattLand non si butta via niente e anni
più tardi, ai tempi di «Ruth Is Stranger
Than Richard», ecco che con qualche ritocco
quella «chiacchierata a passo lento»
diventerà Soup Song – più articolata, complessa,
con la voce forte di due sax.
Con i distinguo ho finito per minimizzare
metà del cd, ma non
vogliatemi male, anche
perché l’altra metà vale
da sola il biglietto. Rivmic
Melodies è la prima stesura
della prima facciata di
«The Soft Machine Volume
Two», quella che i discografici
vollero cervelloticamente
spezzettare in «brani», trovando a tutti i costi titoli per
i diversi frammenti. Nel demo ritrovato
c’è praticamente tutto, dalla Introduzione
Patafisica al Pierrot Lunaire, compresa la
parte dell’alfabeto inglese che però non è
concisa come nella versione definitiva ma
capricciosamente estesa, un gioco di echi,
riflessi, rumori che allieterà l’animo dei
canterburyani in ascolto. Al divertimento
della musica si accompagna lo spassoso
ping pong fra Wyatt e Hopper a proposito
di chi ha composto cosa. Il mondo alla
rovescia: Hopper sostiene che il suo nome
venne usato solo per questioni di diritti,
Wyatt giura che no, lui fu solo giardiniere
di semini piantati dall’amico. Difficile
stabilire chi abbia ragione, anche perché
la memoria di Robert, lo abbiamo detto,
ha four thousand holes come quelli di A
Day In The Life. Quando i curatori della
raccolta gli fanno ascoltare il quarto demo
sopravvissuto, Chelsa, lui trasale e balbetta:
mmmh, la musica dev’essere mia, e il
testo non può che essere
di Kevin Ayers, Chelsa
era una ragazza di Canterbury
che gli piaceva –
però, davvero, non ricordo
niente. Peccato che da
ulteriori indagini emerga
che il testo non è del
povero Kevin ma di Daevid
Allen, nella notte dei tempi Softs. In ogni caso il fascino della
canzone (con un ballonzolante Hammond
che fa quasi Procol Harum) non sta nei
crediti bensì nello sviluppo musicale; ancora
una volta nulla si perde, nulla si distrugge
e qualche anno dopo, ai giorni dei
Matching Mole, l’idea prenderà forma più
precisa con il titolo di Signed Curtain.
In un bel libro di John McDermott con
Eddie Kramer appena ristampato in Italia
(Jimi Hendrix Sessions, Giunti) è scritto che
Hendrix usò i Record Plant solo fino al 6
novembre 1968, per poi tornare a fare vita
on the road. Quindi dobbiamo presumere
che Wyatt smise di registrare intorno a
quella data, e in capo a qualche settimana
tornò in Inghilterra perché, parole sue,
«avevo nostalgia di casa e mi mancava la
pioggia». Il 1969 sarà un anno fondamentale
per lui, l’anno del «Volume Two», la
stagione della rifondazione Soft Machine
senza più Ayers, prima in trio poi in quartetto
con Elton Dean. In realtà, nonostante
le prodezze, la vita di gruppo non fa per
Robert e quei giorni passati in America
da solo sono un riuscito esperimento e una
sirena che presto lo porterà a «The End Of
An Ear». Per lo smemorato protagonista,
è questa la morale di «’68»: «È chiaro che
stavo immaginando una vita artistica mia
e non di gruppo, una musica che potessi
realizzare da solo, come il pittore che avrei
sempre voluto essere».
|