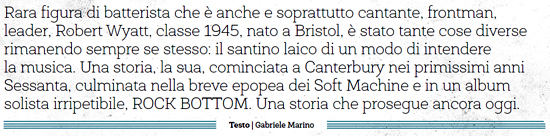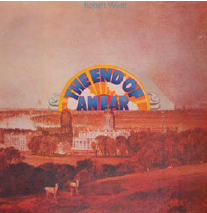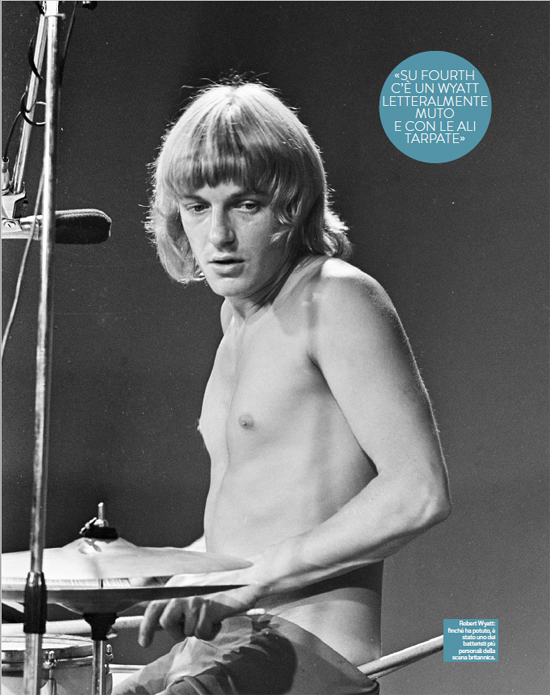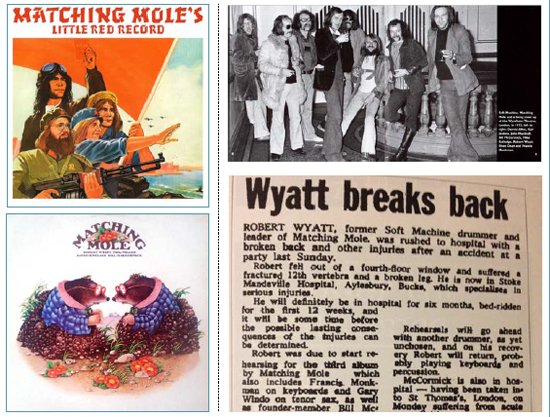| |
|
|
 Robert Wyatt La Voce Sottile della Talpa Dada - Classic Rock El Visionari del Rock - 2017 Robert Wyatt La Voce Sottile della Talpa Dada - Classic Rock El Visionari del Rock - 2017
Généalogie
Di tutte le genealogie che attraversando
la storia del rock
ne segnano i corsi e gli snodi,
quella del rock di Canterbury è una delle più importanti, vitali,
intricate, divertenti. Qualcosa di simile
accadrà poi, in un altrove e in un altroquando,
a Louisville, nel Kentucky, alla
fine degli anni Ottanta, per il post-rock
di matrice punk. Lì tutto era cominciato
con gli Squirrel Bait, una band di poco
più che adolescenti. A Canterbury, nel
Kent (Inghilterra: niente a che vedere
col Kentucky), trentamila anime adagiate
sulle rive dello Stour, cento chilometri
a sud-est di Londra, nella prima
metà dei Sessanta c’è fermento. È il
fermento del movimento beat, del movimento
underground, del movimento
studentesco: insomma, del Movimento,
che mescola assieme, inscindibili, letteratura,
arte, politica e vita. Anche qui
i nostri eroi sono poco più che adolescenti.
Dei ragazzini, a dirla tutta. Tutti
tranne uno, che è un po’ più vecchio ed è ammantato di un’aura esotica, di un’aria algida e sardonica, allo stesso
tempo. È un tipo misterioso, un po’ figura paterna e un po’ cialtrone, è uno che ci è e che ci fa, una specie di guru venuto da lontano, per fare proseliti. Si chiama David, ma presto aggiungerà per vezzo distintivo una “e” al nome, diventano Daevid Allen. Australiano, chitarrista, poeta, beatnik, intellettuale do-it-yourself, nel 1960 prende il fagotto e si mette a viaggiare in lungo e largo per l’Europa. Arrivato in Inghilterra si sente a casa sua, incontra William S. Burroughs, si mette a fare il talent scout e fonda un power trio free jazz – siamo nel 1963, siamo a Londra – assieme a due che hanno sedici anni: Robert Wyatt (che all’epoca si chiama ancora Robert Ellidge e che ha conosciuto Allen perché i suoi genitori gli avevano affittato una camera vonella loro casa di Canterbury) alla batteria, e Hugh Hopper (compagno di scuola di Robert) al basso. Sedici anni.
Quello che sorprende non è tanto
che in breve tempo il Daevid Allen
Trio non riceva più richieste
per suonare nei club, quanto che
ne abbia ricevuto una, la prima.
Siamo in piena epoca surf e beat,
il free è ancora un non-linguaggio
acerbo e per iniziati, mentre nella
praticamente unica testimonianza
che ci resta della cosa, Live
1963, registrato al Marquee londinese
e pubblicato esattamente
trent’anni dopo, quello che sentiamo
è un tipico esempio di “too
much, too soon”, di “no commercial
potential” (oltre che, certo, di
“velleità che non corrispondono
esattamente alle capacità”).
Ascoltando, si capisce molto bene
perché il tutto durerà giusto una
manciata di esibizioni, spalmate
nell’arco di una manciata di mesi
appena. In queste smozzicature
di free jazz che sembra suonato
con dei giocattoli e da dei bambini,
sentiamo un po’ della chitarra
aliena di Derek Bailey (che
però in quel 1963 esordiva in un
jazz ancora tradizionale con i futuri
avanguardisti Tony Oxley e
Gavin Bryars), e addirittura già
Captain Beefheart, la No New
York dei DNA, o il dada bruitiste degli Half Japanese. E anche il antautorato “no-folk” di Daniel
Johnston, se questi lacerti devono
servire da tappeti per gli sbraitamenti
beat di Allen.
Too much,
too soon… Troppe visioni profetiche.
A un certo punto, verso metà
disco, nella jam si affaccia ospite
il pianoforte di un altro ragazzo di
talento, si chiama Mike Ratledge,
ha diciott’anni, è un altro compagno
di scuola di Wyatt e Hopper.
Il gruppo finisce come deve finire
e Allen se ne ritorna a Parigi, dove
già era passato approdando dalla
sua Melbourne e dove aveva già
avuto modo di fare cose con Terry
Riley (perché ognuno si sceglie i
compagni di merende che si merita).
Wyatt e Hopper, ancora sulla
scia, estetica e fisica, dello zietto
australiano (lo raggiungono a
un certo punto a Maiorca, dove
Wyatt prende pure lezioni di batteria
da un vecchio jazzista spagnolo),
mettono in piedi una band
che più che una band è un collettivo,
che più che un collettivo
è un’idea, un’idea chiamata Wilde
Flowers. Sono loro due e altri
compagni di scuola e d’infanzia:
il fratello di Hugh, Brian Hopper,
e due ragazzi che si chiamano
Richard Sinclair e Kevin Ayers.
Ascoltare le registrazioni, anche
qui, sbucate fuori ufficialmente
solo trent’anni dopo, sparse tra
la raccolta di demo e inediti THE
WILDE FLOWERS e i quattro volumi di CANTERBURIED SOUNDS,
fa un effetto davvero strano:
aspri e allo stesso tempo succosi
come frutti acerbi, vi ascoltiamo
già tutti i tic e le firme della cosa
che sarà poi il nostro Wyatt. C’è la
sua voce elegantemente sgraziata,
sottile, ondivaga e perturbante,
c’è il gusto insistito per l’irregolarità
di forme e strutture, per
la diluizione delle atmosfere, per
una certa jazzizzazione del pop,
per lo schizzo folle e improvviso.
Soprattutto, rispetto alle tracce
superstiti dell’Allen Trio, che in
confronto sembrano punk-punto-
e-basta, c’è in nuce tutta l’agrodolce
fragranza delle migliori
cose del primo grande frutto maturo
dell’estro wyattiano, i Soft
Machine.
Epicentro, assieme ai Caravan, e
anche loro gemmazione di questi
benedetti Wilde Flowers, della cosiddetta
scena di Canterbury (etichetta
che viene stiracchiata fino
a includere Comus e Henry Cow,
che di Canterbury non erano, ma
che dei canterburiani erano amici
e ne condividevano l’estetica), i
Soft Machine hanno rappresentato
in maniera quasi dizionariale la
musica che piaceva, soprattutto
ai giovani europei colti e ribelli,
ma di educate letture, educate
visioni ed educati ascolti, alla
fine degli anni Sessanta. I Soft
Machine erano uno di quei nomi,
giusto per dire, sempre citati da
Riccardo Bertoncelli, esempio par
excellence di liberazione e di musica
totale, di sperimentazione, di
avanguardia pop: era la loro una
“musica senza etichette”, “uguale
a se stessa e basta”, una “musica
per morire completamente”.
È attraverso i vari Bertoncelli di
mezza Europa che i Soft Machine
sono entrati nell’immaginario
culturale di un’epoca, piccoli
eppure grandissimi, messi come
sotto una lente d’ingrandimento,
radiografati, vagliati al metal
detector. E Robert Wyatt ne era
il punto focale. Sintomo e sintesi
di un’epoca, anche nella loro
parabola più tarda e meno celebrata,
avendo rappresentato alla
perfezione la transizione verso
l’elefantiasi delle derive post-psichedeliche
e post-prog, leggasi il
jazz-rock, la fusion intrippata del
BITCHES BREW di Miles Davis –
nel migliore dei casi – e i manierismi
baroccheggianti-neoclassicheggianti-sinfonici dei virtuosi
dello strumento di turno.
MACCHINE PERTURBANTI
"I Soft Machine nascono, ancora
e di nuovo, sotto il segno duplice
di Allen e di Burroughs, come
chiarisce subito il nome, preso
dal romanzo dello scrittore che,
nel 1961, inaugurò la trilogia in
cui applicava sistematicamente
la tecnica del cut-up. Siamo
nel 1966 e la band è composta
da Wyatt, Ayers, Allen appunto
e Ratledge. Allen rimolla molto
presto, letteralmente bloccato al
di qua della Manica per questioni
di visti e permessi revocati e con
in testa fantasmagorie tutte sue
che necessitano di uno spazio
tutto loro: andrà a creare i Gong,
altro pilastro del suono e dell’immaginario
canterburiano. Ayers
resiste fino al primo disco, poi
farà Kevin Ayers e basta. Cosicché,
dal secondo album in poi, la
formazione, pur sempre aperta
a ospitate varie (Canterbury significa collettivo e laboratorio),
diventerà Wyatt (voce, batteria),
Ratledge (tastiere) e il ritornato
Hopper (basso). I primi due album
dei Soft Machine sono un
caleidoscopio stordente di idee, di
trovate, citazioni, ammiccamenti,
gag, frammenti poetici, momenti
(r)umoristici che dipingono alla
perfezione gli anni di cui sono
figli. Il primo, l’omonimo THE
SOFT MACHINE, prodotto da due
big come Chas Chandler (bassista
con gli Animals e pigmalione di
Hendrix) e Tom Wilson (produttore
scansafatiche che aveva firmato però l’esordio di Velvet
Underground e Zappa, il Dylan
elettrico, Simon & Garfunkel, il
free jazz più avant, nonché gli
stessi Animals), viene registrato
in aprile e pubblicato nel dicembre
del 1968, mentre l’Europa è
una sorta di barricata perenne
tra libri, libretti rossi e molotov.
L’effetto patchwork colto e disordinato
è forte e i brani puntano a
stordire l’ascoltatore, mimando
quasi l’assalto fisico (fin dall’iniziale
Hope For Happiness).
VOLUME TWO, che esce, autoprodotto
stavolta, nel 1969, sembra
in qualche modo addomesticare
la formula, o comunque gestirla
con maggiore oculatezza, regalando
anche squarci di straordinario
lirismo wyattiano, pur
nell’autocompiacimento più programmatico
del nonsense (la Pataphysical
Introduction divisa in
due segmenti) e tra omaggi espliciti
a Zappa, a Hendrix, al guru della letteratura postmoderna
Thomas Pynchon, a Schönberg.
Robert porta la libertà, l’elasticità
del jazz nel batterismo rock, ma
senza perdersi negli shuffle dello
swing, per carità: il suo orizzonte
ideologico è quello del free e si
sente forte e chiaro. La sua voce è
uno sforzo di equilibrio continuo,
il volo di un uccello colpito, che
cambia rotta, ma non casca mai
per terra e sparisce alto. Soprattutto,
è una voce unica, al di là del
complimento implicito che connota
l’aggettivo, in senso stretto:
non ce n’è un’altra simile, davvero
“uguale a se stessa e basta”.
Se nel disco che si chiamerà
FOURTH (1971) c’è ancora Wyatt
alla batteria, un Wyatt letteralmente
muto, che non canta, perché
l’andazzo ormai è quello, e
con le ali tarpate, che neppure
scrive nulla, in quel THIRD 1970)
che è già comunque il disco di
una band profondamente diversa da quei Soft Machine dada-sessantottini
immediatamente precedenti,
un disco che vede Wyatt
all’angolo (le foto delle session lo
ritraggono parcheggiato su una
sedia, scazzatissimo), messo in
minoranza politico-estetica da
Ratledge e Hopper, in quel disco
c’è l’alba di questo glorioso tramonto,
un qualcosa che chiunque
ami la musica vorrebbe poter testimoniare
da vicino.
Su Moon In June, diciannove minuti
che, sulla carta, sono null’altro
che un taglia e cuci di spunti e
appunti vari, di cose scritte in vari
periodi e in posti diversi, mischiate
a sbocconcellamenti di pezzi
già editi e addirittura di brani di
amici (neppure accreditati; sono
due canzoni di Kevin Ayers), un
brano che gli altri due Soft si sono
praticamente rifiutati di contribuire
a creare e allora Wyatt se l’è
dovuto suonare e montare in quasi
completa solitudine, su questo Frankenstein sconfitto, lungo diciannove
minuti, nessuno avrebbe
potuto scommettere. E invece
il mostro salta fuori tutto vestito
lucido di miele d’acacia, risultando
di abbacinante, imprendibile
bellezza. Non vogliamo togliere
niente agli altri pezzi della collezione,
Facelift, Slightly All The
Time e Out-Bloody-Rageous,
mirabili, avvincenti costruzioni
progressive. Ma qui siamo – è un
concetto che torna spesso, avrete
notato – in un altrove, in un’altra
dimensione. Si potrebbe facilmente
indugiare nella retorica
dell’ispirazione e dell’ineffabile
nel maneggiare questa cosa qui,
eppure la sua bellezza sfuggente
è perfettamente spiegabile, sta
tutta in un banalissimo, sapiente
dosaggio di elementi. Cosa rara
peraltro in un brano nella tradizione
delle grandi suite del rock,
da Sister Ray dei Velvet Underground
in avanti, banco di prova
per improvvisazioni, sperimentalismi
collagistici e rumoristici per
definizione. In Moon In June c’è
la voce leggermente come soffocata,
sul punto di non farcela, di
Wyatt, una voce nondimeno agile
e in grado solo lei d’inerpicarsi
lassù. C’è una batteria legnosissima.
Ci sono due note di basso.
Due note di tastiere elettriche.
Basta. E bastano a tratteggiare un’atmosfera densa e sospesa,
che sembra raccontare la storia
di un abbandono sognante,
unico possibile antidoto al nonsenso
delle cose della vita.
Wyatt qui trova l’equilibrio perfetto tra
urgenza di dire e volontà di non
compromettersi dicendo troppo,
come fa dire bene al suo alter ego,
in bilico tra ciò di cui si ha bisogno
e ciò che si vuole. Quando il
pezzo sembra ormai in procinto
di stingere anch’esso nel jazzrock
proggheggiante che lo attornia,
la voce di Wyatt decide di
chiudere in bellezza e ricomincia
a giocare con la propria coda, un
po’ planare di delfino sott’acqua,
un po’ Thema di Luciano Berio.
Qui finiscono i Soft Machine di
Robert Wyatt, i Soft Machine che
sono stati Robert Wyatt, con uno
dei suoi segni più maiuscoli.
Messo a mezzo servizio in casa
propria, Wyatt coglie l’occasione
per realizzare, quello stesso anno,
1970, il primo disco solistico, etichettato
da uno di quei giochi di
parole un po’ bambineschi, un po’
tetri e apocalittici che tanto gli
piacciono: THE END OF AN EAR.
Finisce un’epoca, ma lui continua.
Bello, ispido e fragrantemente artigianale,
l’album fa però un po’
il gioco della svolta recente dei
Soft Machine, perché non presenta
brani cantati o anche solo
vocaleggiati. È un disco ingegnosamente,
ingegneristicamente
creativo, avventuroso, suonato
per la stragrande maggioranza in
solitaria e frutto di meticolose sovraincisioni,
in cui la sensazione
della liberazione personale emerge
palpabile. Ma a cui manca una
cosa, quella cosa.
LA TALPA ABBINATA
(COL CULO PER TERRA)
Nel 1971, Wyatt, separato in casa
con quella che era stata la creatura
sua, ne crea il Doppelgänger
sfottò, fin dalla ragione sociale:
Matching Mole, gioco di parole
con il corrispettivo francese di
Soft Machine (machine molle).
La band si rifornisce dalla fucina
di musicisti del giro Canterbury
che Wyatt conosce da sempre
come le sue tasche (due Matching Mole saranno poi i cardini degli
Hatfield and the North, che,
allo stesso tempo, sono uno spin
off dei Caravan) e, come le band
seminali da cui si era sviluppata
tutta la genealogia canterburiana,
avrà vita bruciante ed effimera.
Due soli gli album all’attivo,
utili a chiarire, al di là del valore
specifico e qualora fosse ancora
necessario, due cose importanti:
il talento melodico di Wyatt (O
Caroline, che apre l’esordio eponimo)
e le sue posizioni politiche
(MATCHING MOLE’S LITTLE
RED RECORD è, maoisticamente,
il suo “dischetto rosso”).
Nel 1973 la band si sfascia, troppi
fili, troppi giri la attraversano e
più che articolarne i movimenti la
legano, la paralizzano. Wyatt, per
conto suo, è sempre più sbandato,
lo stile di vita sregolato che la
sua produzione musicale e il suo
modo di presentarsi lasciano intuire
ne sta segnando pesantemente
il viatico. Come compagni
di bevute, in gioventù, aveva avuto
maestri come Hendrix e, pericolosissimamente,
Keith Moon.
Le loro sono lezioni che non si
scordano. La band risorge con un
rimpasto di formazione insperato
e si appresta a registrare un terzo,
nuovo disco. Ma. Però. Se la tragedia
è una commedia rovesciata o,
meglio, specchiata, vista negli occhi
dell’altro, capiamo bene come
la gag slapstick di scambiare una
porta per finestra fa ridere molto
poco, se a essere scambiata per
porta è una finestra e ci si trova,
ubriachi fradici di tequila e Southern
Comfort (routine questa con
sopra la firma di Moon), al quarto
piano di una casa non propria. È
il primo giugno del 1973. In cielo
c’è la luna. Robert è a una festa,
a Londra, e c’è mezza Canterbury
suonante. Mette il piede fuori,
a un certo punto. Vola giù. È fortunato,
per due ordini di motivi.
Non muore. E, come dirà lui stesso,
trent’anni dopo: «Visto lo stile
di vita che conducevo all’epoca,
l’incidente la vita me l’ha salvata,
perché me l’ha fermata». L’effetto
collaterale di cotanta fortuna però
è la paralisi totale della parte inferiore
del corpo. Robert si rompe
la schiena e il Wyatt batterista
istintivo, timbrico e genialoide
scompare in un istante. Resta l’altro
Robert, l’altro Wyatt, che poi è
in fondo quello più altro, quello
più alieno e nonostante tutto più
nostro. Nonché quello più influente e capace di tenerli assieme
tutti quanti, col filo rosso sottile di
una voce unica: il casinaro patafisico
scatenato e il bozzettista di
scorci lirici. Il ritorno su disco di
Wyatt dopo l’incidente testimonia
un lavoro che non è più accumulazione,
stratificazione, ma panneggio,
con qualche picchiettatura
studiata ad arte. Ci sono tante cose
dentro, molte peraltro pensate, decise
e scritte prima del volo. Tante
cose, ma ciascuna ha il suo spazio,
il suo silenzio attorno.
Ci sono dentro tanti amici, come
sempre: il disco è prodotto da Nick
Mason dei Pink Floyd e suonato
da Mike Oldfield, Ivor Cutler, Fred
Frith, Hugh Hopper, Richard Sinclair,
tra gli altri. È personale questo
disco, parla di quello che è successo,
fin dal titolo un po’ crudele, ma allo stesso tempo è capace di
trascendere il momento e i perché
del caso, diventando qualcosa di
più grande, di più generale, di più
astratto. Quando si parla di ROCK
BOTTOM (1974), da sempre alto
anzi altissimo nelle classifiche dei
migliori dischi di popular music di
tutti i tempi (come non ricordare
l’argento fisso assegnatogli da Piero
Scaruffi, dietro a TROUT MASK
REPLICA di Captain Beefheart),
non si parla praticamente mai di
musica folk, eppure l’atmosfera
stranitamente bucolica che vi si
respira dentro fa pensare proprio a
un folk d’altrove (di nuovo), come
un folk lunare. In pieno contrasto
con il titolo, ulteriore calembour
dai recessi profondi dell’anima,
quando non resta più che raschiare.
Con il culo per terra, toccato il fondo, si può solo risalire, rischiare.
Capolavoro intimista di dolore,
sublimato in piccoli tocchi trattenuti
di percussioni, tastiere e
fiati, tappeto rosso sfilacciato ed
elegantissimo per una voce mai
così sofferta, mai così protesa oltre
se stessa, basterebbero la tetra
canzone d’amore fatta di brina e di
nebbia che è Sea Song, basterebbe
la filastrocca idiota e disperata di Alifib a fare di questo fondale, di
questo “punto più basso” il punto
più alto di tutta una carriera. Lo
era già prima, sia chiaro, ma con
ROCK BOTTOM Wyatt diventa
per sempre uno dei santini assoluti
dell’alternativismo musicale
di quegli anni: ne è la mascotte.
Cuore pulsante e prezzemolo
della scena canterburiana in tutte
le sue ramificazioni, nei Soft Machine
aveva fatto tournée con la
Jimi Hendrix Experience, era stato
sfiorato da un Kim Fowley dall’occhio
lungo (se li voleva accaparrare
lui) e aveva suonato in segreto
per il Syd Barrett cappellaio matto
solista. Dopo l’incidente, Wyatt
sarà guest fisso di tutta la scena
avant/sperimentale che unisce art
rock, prog, jazz rock, “unpopular
popular music” e sperimentazione
extra-accademica: suonando con
Brian Eno, con gli Henry Cow, interpretando
John Cage, arrivando,
in anni più recenti, fino a Pascal
Comelade e, significativamente, a
Björk. Nel dispiegarsi del suo profilo
da solista, acciaccato e nobile,
la sua poetica si è andata affinando,
certo, stilizzando, nessun dubbio,
ma in fondo è sempre rimasta
la medesima: un gioco surreale,
orgogliosamente anche un po’
naïf, con la materia musica e con
la voce pensata come fiato di vita e
strumento, trascinato da intuizioni
folgoranti e da brucianti passioni.
Anche a costo di apparire fuori
fuoco, fuori posto. Altrove rispetto
all’altrove suo proprio. Nello stesso
anno di ROCK BOTTOM, per
esempio, Mason gli produce anche
un singolo che arriva fino a Top of
the Pops, dove Wyatt, tra l’imbarazzo
del network e probabilmente
di almeno parte del pubblico (in
sala e davanti agli schermi), si esibisce
tutto storto com’è sulla sua
carrozzina, in un playback fuori
sincrono, a metà tra l’autoipnotizzato
e lo scatenato. Il pezzo è una
cover piuttosto fedele di I’m a Believer dei Monkees. Anni dopo farà
sua Guantanamera (si trova nel
disco di cover politiche NOTHING CAN STOP US, del 1982; dentro
anche il gioiello Shipbuilding,
scritto da Elvis Costello, contro la
guerra nelle Falkland), ma con un
trattamento più personale, pesantemente
influenzato dallo spirito
dell’epoca e, quindi, tutta affilati
strapazzamenti che andavano fatti
per dire di essere new wave. Stefano
Tamburini, nei panni del critico
musicale Red Vynile, sulle colonne
di «Frigidaire», non avrà peli
sulla lingua nel portare all’estremo
un’opinione certamente diffusa,
almeno tra quelli che erano stati i
fan barricadieri dei Soft Machine
e del Wyatt folletto psichedelico,
riguardo a operazioni del genere,
indugiando nella descrizione di
cosa gli avrebbe fatto, allo “storpio”,
per aver osato produrre certa
“merda”.
COMICA FINALE
Ecco, il rapporto con le cover e
quindi con l’altro da sé è una chiave
d’accesso certamente laterale ma
in fondo privilegiata per entrare dentro le dinamiche della musica
di Wyatt. Bricoleur senza vergogna,
remixatore ante litteram delle
musiche sue, degli amici e delle
figure che ne hanno influenzato
il percorso musicale, Wyatt ha al
momento congelato la carriera
solistica, puntellata da episodi eccellenti
(tutti citano almeno RUTH
IS STRANGER THAN RICHARD,
1975; SHLEEP, 1997; CUCKOOLAND,
2003, e noi ci accodiamo
felicemente), con la moglie pittrice
Alfreda Benge sempre più coinvolta
e determinante (nonché responsabile
di praticamente tutte le
copertine più iconiche del marito),
con un disco very Robert Wyatt,
che per il 30% almeno è un sorprendente
disco di cover. Parliamo
di COMICOPERA, anno 2007,
disco dell’anno per «The Wire»,
storico e supersnob magazine di
ricerca che, con gesto romanticamente
demodé, lo ha preferito al
capolavoro di un altro suo santino
alt, stavolta recente, il produttore
dubstep Burial, che proprio a fine 2007 aveva pubblicato il suo secondo
– e, anche qui, al momento
ultimo – album UNTRUE. COMICOPERA
è un sorriso struggente,
una mini-galleria di piccoli gouache,
rigorosi e volutamente appesi
storti al muro, organizzati in tre
atti; ognuno di essi racconta una
storia bella, che un po’ fa ridere e
un po’ fa piangere. Uno dei picchi
assoluti e, possiamo dirlo, francamente
inattesi del disco, è la cover
da pelle d’oca della già splendida
Del mondo dei nostrani CSI.
Canzone del mondo primitivo, di
freddo, sangue, carne e lana, profondamente
ferrettiana, Wyatt la
fa sua e la grazia con la sua voce
speciale, qui davvero fragilissima,
come di chi sta per addormentarsi
in letargo, emergendo ancora una
volta come il maiuscolo bardo della
musica che ci piace che è.
Gabriele Marino
|